 Un contributo stimolante e sempre attuale del prof. Comparini sullo stato delle scienze morfologiche in Italia, pubblicato su: Italian Journal of Anatomy and Embriology del 1992, vol. 97 (n. 4), pagg. 217-219.
Un contributo stimolante e sempre attuale del prof. Comparini sullo stato delle scienze morfologiche in Italia, pubblicato su: Italian Journal of Anatomy and Embriology del 1992, vol. 97 (n. 4), pagg. 217-219.
Leonetto Comparini. L’insegnamento delle discipline anatomiche continua a soffrire di vicende poco favorevoli e rischia di assestarsi in una dimensione di grave sacrificio fino a ridursi ad un esercizio didattico essenzialmente libresco. Più d’uno sono i fattori che concorrono a mantenere, e se mai ad aggravare, questo «trend» negativo:
— la riduzione temporale imposta dall’attuale ordinamento didattico che, togliendo quei tempi e quegli spazi «lunghi» indispensabili per insegnare e «ritenere» una disciplina delle dimensioni dell’anatomia, finisce per penalizzare sostanzialmente l’insegnamento e lo studio della macroscopica;
— la mancanza ormai totale di materiale cadaverico, peraltro sempre più
flebilmente lamentata, giacché si cala in un contesto di pratica inattuabilità di un insegnamento al tavolo anatomico, per scarsità di tempo e di competenze;
— un’attività di ricerca sempre più «distraente» in quanto in gran parte
orientata verso tematiche «di confine», che in buona sostanza sconfinano ampiamente verso discipline «più giovani», «più moderne», «più scientifiche» dell’anatomia, che con l’anatomia intrattengono solo vincoli di lontana parentela. Per cui sempre più difficile è (e diventerà) strappare il giovane studioso dal computer o dal laboratorio di biochimica per riportarlo a «sacrificare» parte del suo tempo allo studio ed all’insegnamento della macroscopica; anche per
— lo scarsissimo od il nessun peso che l’attuale prassi concorsuale attribuisce all’esperienza didattica specifica per la valutazione delle nostre carriere; senza contare
— la perseverante mancanza di competività che ormai allontana i giovani laureati in medicina (e quindi una «mentalità» medica) dai nostri istituti.
Con queste premesse il rischio che ben presto correrà la disciplina (ridotta ad una dimensione essenzialmente «laboratoristica») sarà quello di scomparire inghiottita da strutture dipartimentali verticalizzate, o comunque interdisciplinari, nelle quali l’anatomia avrà un ruolo probabilmente «ancillare», essendo mostruosamente mutilata della sua identità e quindi, sul piano didattico, facilmente mutuabile.
Primi segni di una inarrestabile evoluzione tendente a mutarne sostanzialmente il ruolo ed il destino? Può anche essere. Ma se è vero che al letto del malato una semeiotica fisica non viene quasi più insegnata né praticata, a tutto vantaggio di una semeiologia strumentale sempre più affinata e totalizzante (alla quale è ormai affidata buona parte del discorso diagnostico), è pur vero che sempre maggiore è la rilevanza che assume nella pratica clinica la diagnostica per immagini. Non scompare dunque, ma se mai si rafforza, l’irrinunciabile conoscenza della forma anatomica; nel caso specifico, tanto per la lettura dell’immagine radiologica classica (con o senza mezzi di contrasto) quanto per la più complessa decifrazione dell’immagine ecografica, scintigrafica, tomografica, fino al suggestivo ritorno alla fedeltà formale della risonanza magnetica.
Ma occorre «possederla» questa «conoscenza della forma anatomica», che è conoscenza della morfologia in senso completo: cioè della situazione, della forma esterna, delle dimensioni, dei rapporti, delle macrostrutture di un organo; in una parola conoscenza d’insieme della macroscopica: dai dettagli della sistematica alla sintesi della topografica. Difficile, se non impossibile, aver impressa una conoscenza delle disposizioni morfologiche tanto da poterne riconoscere, nell’immagine che si osserva, eventuali devianze dal normale, senza averne avuto una qualche dimestichezza di osservazione e di studio.
Ecco quindi, contro certe contrarie evidenze, l’esigenza di un «ritorno» allo studio ed all’insegnamento della macroscopica. Occorrerà farlo con i mezzi attualmente disponibili: certamente sul cadavere (quando sia possibile), altrimenti sfruttando quei metodi di conservazione degli organi che oggi consentono almeno di farsi un corredo sufficientemente completo di pezzi «veri» da studio e da dimostrazione.
Occorre che gli studenti (i futuri medici) «vedano» queste cose, per imprimerle nel loro bagaglio di conoscenze con l’indispensabile ausilio della memoria visiva, capace, a distanza di tempo, di richiamare alla mente, con immediatezza, quell’immagine che solo un’esperienza di studio attento e riflettuto (non frettoloso e superficiale) avrà lasciato.
L’apprendimento di una disciplina descrittiva come l’anatomia è affidato in buona misura al contatto diretto con l’oggetto di studio. In pratica lo studente ricorderà meglio ciò che ha «visto», che ha avuto modo di osservare con attenzione; dimenticherà invece, presto o tardi, e con facilità, le cose solo lette o sentite.
Ma se è vero (come è vero) che il futuro medico ricorderà ciò che ha «visto» assai più ed assai meglio di ciò che ha soltanto «sentito dire», è anche vero che il docente finisce per insegnare solo «quello che sa».
Per cui occorrerà anche che i giovani ricercatori di oggi, che avranno domani piena responsabilità di docenza, non trascurino questo studio che è fondamentale per la loro formazione culturale e non tralascino di formarsi anche all’insegnamento della macroscopica.
Tramontata ormai la sala settoria, una buona esperienza in tal senso potrà essere quella di impegnare giovani docenti e studenti in quella didattica teorico pratica a piccoli gruppi che è tra le poche innovazioni valide del nuovo ordinamento; insieme all’inserimento, nel corso integrato di anatomia, degli insegnamenti di anatomia radiologica (che sarebbe bene dovunque attivare ed affidare alla competenza di uno specialista, senza soverchio timore di pericolose invasioni di campo) e di anatomia clinica (per il quale occorre formare e valorizzare — e presto — precise competenze didattiche). Ambedue, anatomia radiologica ed anatomia clinica, utili a motivare e supportare, accanto all’anatomia topografica, un valido «ponte» fra conoscenze anatomiche e discipline applicative, mediche e chirurgiche. Cose, queste, «scoperte» già da qualche decennio: la ricca letteratura didattica in lingua inglese ne è una chiara dimostrazione.
Non operare in questo senso, scrollandosi di dosso (perché nasconderlo?) un comodo immobilismo, vorrà dire spianare il cammino a quel processo di svalutazione della nostra disciplina che è ormai decisamente avviato.
Dovrà essere dunque sollecitudine ed impegno dei docenti di oggi verificare e valutare tutte queste esigenze e adoperarsi a che possano essere soddisfatte.
I meno giovani ricordano certo l’espressione arguta e ricorrente con la quale uno dei nostri Maestri più cari, il Prof. Curzio Massart, salutava, negli ultimi tempi, qualche comunicazione sui temi di ricerca più «attuali»; «Coraggio ragazzi! Tra cinquant’anni si riscopre il femore!».
II Maestro vedeva — come sempre — giusto: solo che il tempo cammina veloce, e sarà prudente anticiparla questa riscoperta.
Filed under: Piccola scienza |




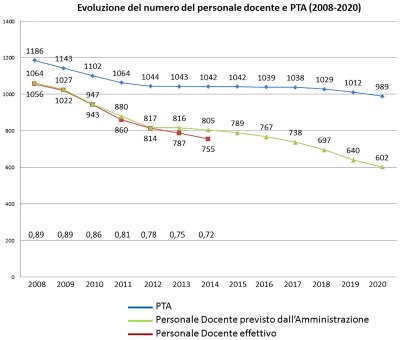

















Lascia un commento